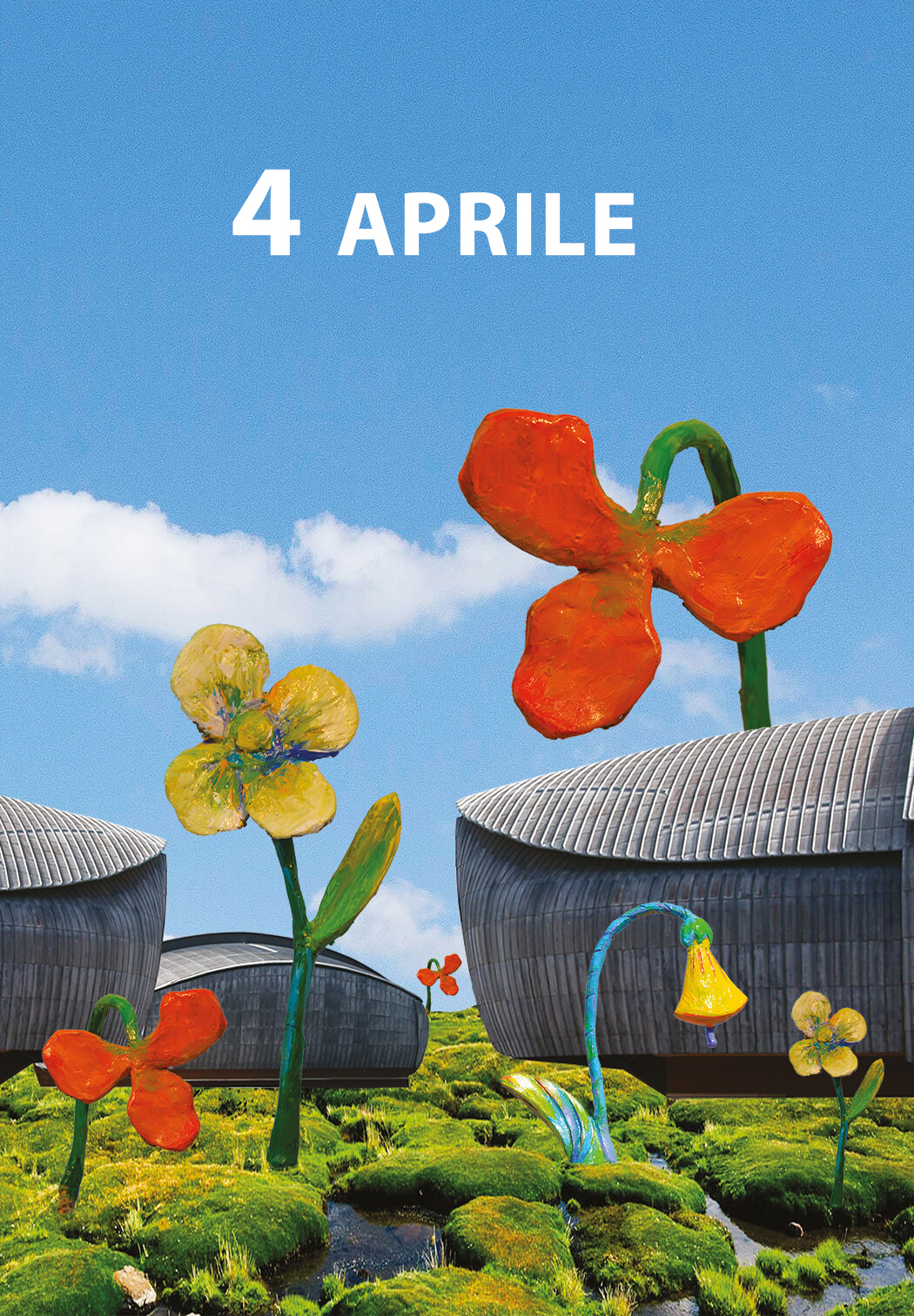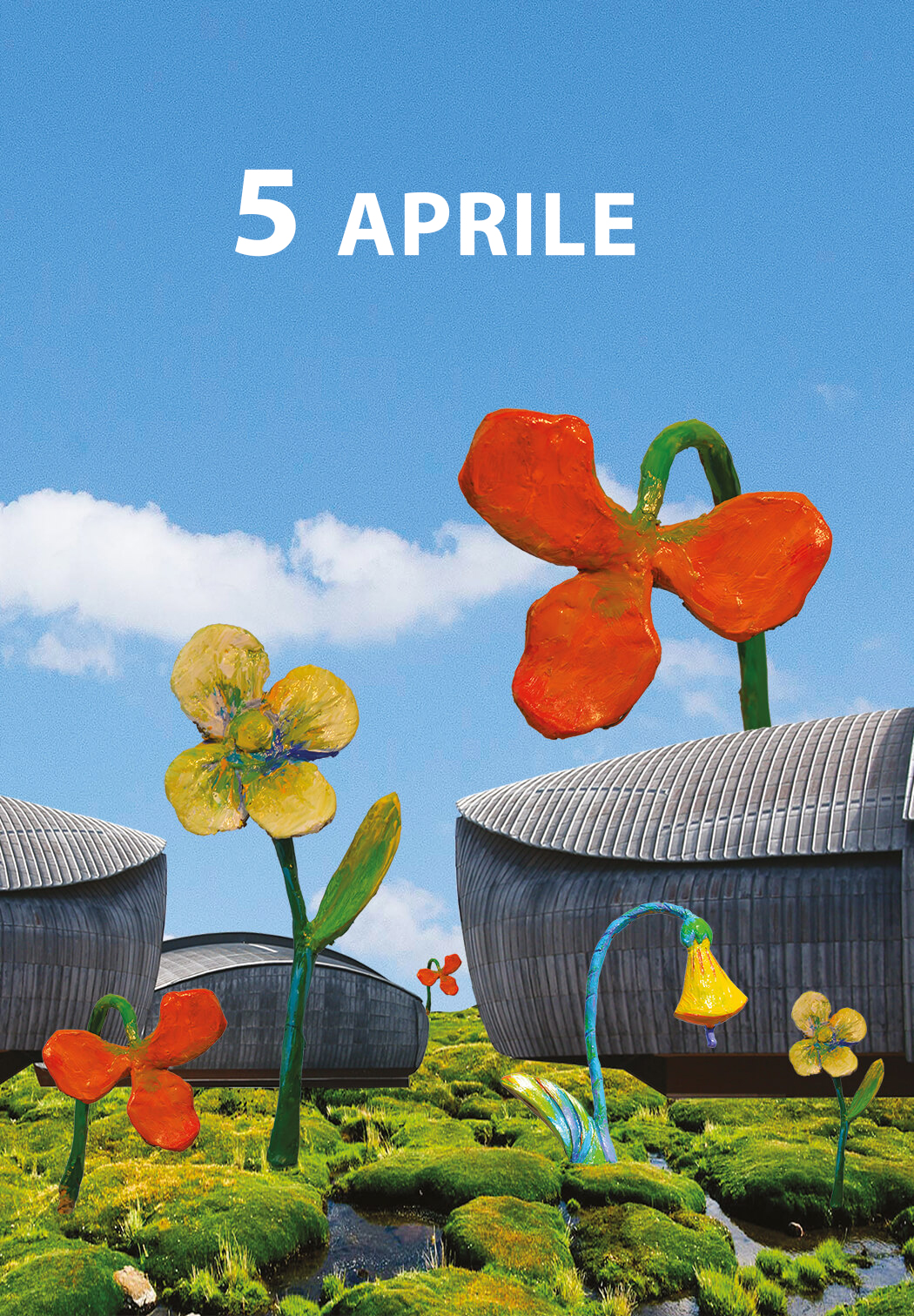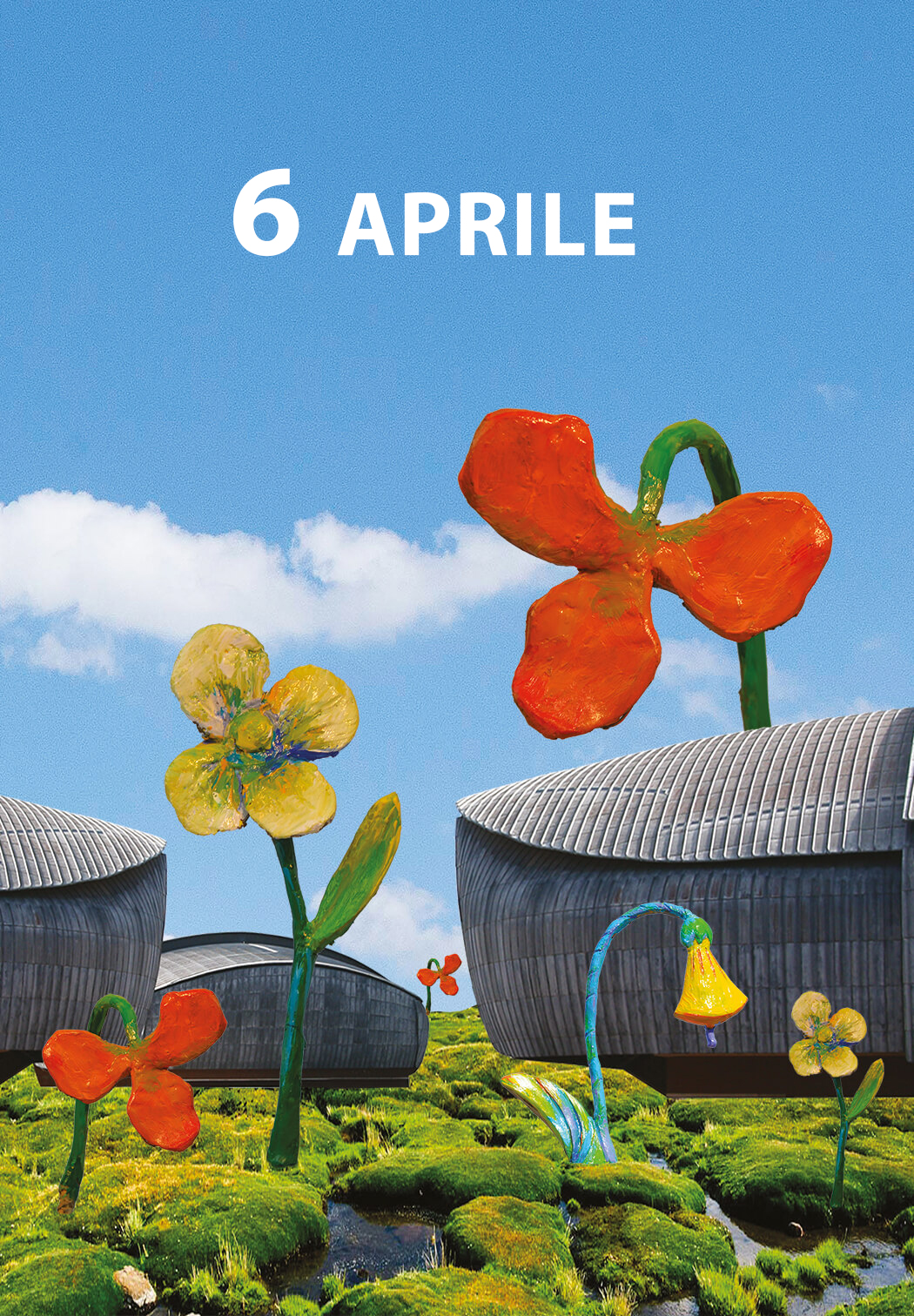Un Bosco per Roma
Nasce il primo bosco urbano temporaneo della Capitale
Ripensare la città ripartendo dagli alberi
Nel maggio 2017, qualcosa di straordinario è accaduto a Roma.
Una visione audace, poetica, rivoluzionaria ha preso forma:
la cavea dell’Auditorium Parco della Musica si è trasformata in un vero bosco urbano.
Vivo. Profumato. Inaspettato.
Il primo nella storia della Capitale.
Oltre 120 alberi tra querce, frassini, olmi, sughere, ciliegi selvatici. Arbusti mediterranei: corbezzoli, lentischi, mirti, viburni. Radure, ombre gentili, profumo di sottobosco, natura vera sotto il cielo di Roma.
Una dichiarazione d’amore
Un Bosco per Roma è stato molto più di un’installazione:
è stato un gesto urbano potente, un invito a ripensare le città con occhi verdi.
Un messaggio chiaro e visionario: portiamo le foreste dove non ci sono
; combattiamo il calore, l’inquinamento, l’isolamento; progettiamo spazi vivi, belli, inclusivi.
Una prova generale di futuro.
Un’anticipazione delle grandi sfide di oggi: clima, salute, biodiversità. Un modo per immaginare piazze verdi, spazi di incontro, luoghi che rigenerano corpo e mente.
Arte, natura, città
Ad accogliere i visitatori, la street art energica e coloratissima di “Giro d’Italia”, un’opera collettiva firmata dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma.
I protagonisti
Ideato da: Fabio Di Carlo e Pan Associati (Benedetto e Gaetano Selleri) , in collaborazione con Fondazione Musica per Roma, realizzato dal Festival del Verde e del Paesaggio, con il contributo vivaistico di Euroambiente Gruppo Zelari e Margheriti Piante e realizzato
Un’idea che continua a crescere
“Un Bosco per Roma” è stato il cuore pulsante della VII edizione del Festival del Verde e del Paesaggio.
Ma anche qualcosa di più:
un seme piantato nell’immaginario urbano.
Un’opera viva che ha sussurrato:
“E se piazze e strade diventassero foreste?”
”E se la città guarisse… grazie agli alberi?”
Roma ha risposto: Sì.

Chi cresce nel Bosco? Una guida botanica agli alberi di Un Bosco per Roma

Acero campestre: eroe delle nostre campagne
Origini e significato del nome
Il suo nome fa già capire molto di lui! Il genere Acer viene dal latino acer, che significa “appuntito, duro, acuto”, un riferimento alla resistenza del suo legno, tanto robusto da essere usato anticamente per costruire lance. L’aggettivo campestre, invece, ci racconta dove ama vivere: tra campagne, ai bordi di campi, nelle siepi e nei boschi di latifoglie.
Dove cresce?
Originario dell’Europa centrale, l’Acero campestre ha conquistato un bel po’ di territorio: lo troviamo in tutta Italia (in Sardegna è presente, ma non autoctono) e ama ambienti diversi: dai boschi umidi alle colline soleggiate, fino alle siepi in mezzo alla pianura.
Ritratto di un campione rustico
Non lasciarti ingannare dalle sue dimensioni contenute. Questo albero può essere un arbusto da siepe o un elegante gigante fino a 20 metri, se lasciato crescere libero. È super resistente: tollera l’inquinamento, sopporta la siccità e ama farsi potare, rendendolo perfetto per giardini, siepi e aree urbane. Cresce lentamente, è vero, ma in compenso dona rifugio a una piccola fauna di insetti, uccelli e mammiferi, contribuendo alla biodiversità.
Una bellezza che cambia con le stagioni
In primavera le sue foglie giovani sono rosate, poi diventano verde opaco sopra e più chiare sotto. Ma è in autunno che dà il meglio di sé, tingendosi di un giallo ambrato che illumina le campagne. I suoi fiori, giallo-verdi, sbocciano tra aprile e maggio e attirano insetti impollinatori, rendendolo anche una buona pianta mellifera. E i frutti? Le famose “elichette” (le samare), che volteggiano nell’aria come piccoli elicotteri.
Non solo bello: è anche utile!
Un tempo, nelle vigne della Pianura Padana, l’Acero campestre veniva usato come tutore vivo per le viti: un alleato verde che sorreggeva i tralci e dava ombra. Le sue foglie, ricche di proteine, sono un ottimo foraggio, e le sue radici ramificate aiutano a stabilizzare i terreni in pendenza o soggetti a erosione. Anche il legno ha il suo perché: inizialmente bianco, poi bruno-rossastro, è compatto e omogeneo, perfetto per piccoli lavori al tornio… e anche come combustibile!
Come riconoscerlo?
Foglie semplici, opposte, con 3-5 lobi arrotondati e margine liscio. In autunno diventano giallo intenso.
Fiori piccoli, giallo-verdastri, riuniti in infiorescenze erette (corimbi).
Frutti: due samare con ali disposte a 180°, che si separano a maturità.
Tronco spesso curvo, con rami che partono bassi. La corteccia diventa scura e fessurata col tempo.
Chioma densa, rotondeggiante e irregolare, può anche avere un portamento arbustivo.
Tra leggende e antichi miti
Nella mitologia greca, l’Acero era legato a Fobos, il dio della paura, forse per le sue foglie che in autunno si tingono di rosso come il sangue. Secondo Virgilio, il celebre cavallo di Troia era costruito proprio con legno d’Acero! E Ovidio racconta che anche il trono del re Tarquinio Prisco era fatto con questo legno. Altro che albero da siepe…

Carpino bianco, l’albero forte, elegante e tuttofare
Cosa ci racconta il nome?
Il nome Carpinus affonda le radici in tempi antichissimi: probabilmente arriva dal celtico car (legno) e pin (testa), perché pare che il suo legno servisse per costruire i gioghi del bestiame. Ma c’è anche chi dice che venga dal sanscrito kar, che significa “duro”. E in effetti, il suo legno è tosto! Il secondo nome, betulus, è un chiaro riferimento alle sue foglie, che ricordano quelle della betulla.
Da dove viene?
È una specie tipica delle zone temperate dell’emisfero nord, presente in gran parte dell’Europa e dell’Asia Minore. In Italia è abbastanza diffuso, anche se non si fa vedere in Valle d’Aosta né sulle isole. Ama le colline e le basse montagne, e lo troviamo fino a 1200 metri di altitudine.
Il tuttofare del bosco (e del giardino!)
Il Carpino bianco è un albero a foglie decidue che ama i boschi freschi e profondi, ma non si fa certo spaventare da freddo, siccità o inquinamento: è una vera forza della natura! La sua rusticità lo rende perfetto per:
barriere frangivento nei campi,
siepi sagomate o decorative (resiste benissimo alla potatura) e persino per labirinti verdi da giardino.
In inverno trattiene le foglie secche sui rami bassi, creando una protezione naturale contro il vento per le colture sottostanti.
Com’è fatto?
Foglie. Forma ellittica, margine seghettato e apice appuntito
. Verde scuro sopra, più chiaro e peloso sotto
Lunghe 5-10 cm, con un picciolo spesso rossastro
.
Fiori. Maschili e femminili separati, ma sulla stessa pianta (è monoica)
. I maschili sono lunghi amenti gialli pendenti
. I femminili sono più corti, eretti, con stimmi rossi ben visibili
Fiorisce tra febbraio e aprile. L’impollinazione? Tutto merito del vento!
Frutti. Piccole noci verdi (acheni) raccolte in lunghe infiorescenze pendule
. Ogni frutto ha una brattea a tre lobi, molto decorativa
Tronco e corteccia
Tronco sottile con scanalature verticali
Corteccia liscia, grigio-bruna, simile a quella del faggio
Chioma
Densa e compatta, forma arrotondata
I rami crescono verso l’alto, ma le estremità pendono con eleganza
Simboli e significati
Il Carpino bianco è considerato simbolo di vigore e vitalità. Un albero forte, resistente e sempre pronto a reinventarsi, proprio come chi ama la natura e la fa crescere con rispetto.

Il ciliegio selvatico : tra fiori, frutti e poesia
Un albero amato da tutti (uccelli compresi!)
Il nome scientifico Prunus avium suona elegante, ma nasconde origini semplici: Prunus richiama il greco prunon (prugna), mentre avium significa “degli uccelli”. Sì, perché questi frutti rossi e succosi fanno impazzire i volatili (e non solo!). In italiano lo chiamiamo ciliegio, o ceresia, parola arrivata da lontano, dall’antica Persia, passando per il latino ceresia. Un frutto che viaggia nella storia e nel gusto.
Dove cresce?
Il ciliegio selvatico è originario dell’area tra Caucaso e Balcani, ma oggi lo troviamo in tutta Italia, soprattutto in collina e in bassa montagna, sia coltivato che in forma più “selvatica” nei boschi e nelle siepi.
Fiori che incantano, frutti che fanno gola
Il ciliegio è un albero a crescita veloce, che può raggiungere i 25-30 metri in condizioni ottimali. In primavera si trasforma in un esplosione di fiori bianchi, leggeri come neve, tra i più amati in assoluto.
Poi, tra maggio e giugno, ecco arrivare le protagoniste: le ciliegie! Rosse, lucide, dolcissime… un richiamo irresistibile per uccelli, scoiattoli e buongustai.
Un albero per tutte le stagioni
Primavera: fioritura spettacolare, perfetta anche come pianta ornamentale.
Estate: i frutti maturano, succosi e zuccherini.
Autunno: le foglie si tingono di giallo oro e rosso cupo, come un quadro impressionista.
Inverno: la silhouette elegante resta visibile, con la sua corteccia che si sfoglia in placche e strisce decorative.
Non solo bello: è anche utile!
Il legno del ciliegio è molto apprezzato in falegnameria: duro, compatto, con sfumature calde rosso-brune.
Le foglie contengono pigmenti naturali usati per tingere.
I fiori, oltre a essere decorativi, attirano api e impollinatori: è una pianta amica della biodiversità.
Il ciliegio viene coltivato per i frutti freschi ma anche da conservare sotto spirito (sì, le famose ciliegine al liquore!).
Come riconoscerlo?
Foglie. Lunghe 5–15 cm, verdi scure sopra, più chiare e pelose sotto.
Margine seghettato, con due piccole ghiandole rosse alla base: dei mini-nectari per insetti!
Fiori. Bianchi, a 5 petali, in piccoli grappoli da 2 a 8 elementi.
Fioriscono tra aprile e maggio, insieme alle prime foglie.
Frutti. Drupe rosso scuro, lucide, con polpa dolce e succosa.
Contengono un nocciolo duro, che protegge il seme.
Tronco e corteccia. Tronco slanciato, con corteccia liscia e rossastra da giovane.
Invecchiando, la corteccia si stacca in placche ad anello, molto decorative.
Chioma. Piramidale da giovane, poi tondeggiante e più ampia con l’età.
Simboli e cultura
In Oriente, il ciliegio è il simbolo della rinascita primaverile ma anche della fugacità della vita. In Giappone è protagonista dell’hanami, la celebre “contemplazione dei fiori”: un rituale fatto di bellezza, poesia e tempo che scorre.

Quercus robur: sua maestà la farnia
Che nome potente!
Quercus arriva dal celtico kaer quer e significa “bell’albero”. Robur, in latino, è tutta un’altra storia: vuol dire forza, vigore, robustezza. Insomma, non è un albero qualunque, ma un vero simbolo di solidità e longevità.
Dove vive?
La farnia è la regina delle querce europee. Vive dalla Scandinavia fino al Mediterraneo, spingendosi anche a 1000 metri di altitudine. In Italia è diffusa in tutta la penisola continentale, specialmente in pianura e collina, nei suoli profondi e freschi. Un tempo dominava nei “querceti planiziali”. Oggi resiste in boschi misti, parchi, siepi campestri e grandi giardini.
Un’icona di resistenza (e biodiversità)
La farnia cresce lentamente, ma può vivere fino a 600 anni — e anche di più! È una pianta rustica, che si adatta a molti climi e ospita una quantità incredibile di vita: fino a 284 specie di invertebrati!
Viene usata nei rimboschimenti forestali; come barriera naturale tra i campi e nei parchi e viali (soprattutto la versione “fastigiata”, dal portamento slanciato e ordinato, perfetta per i viali urbani).
Legno nobile, cuore antico
Il legno di farnia è tra i più pregiati: duro, compatto, con sfumature dal bruno scuro al miele, è usato per:
mobili di qualità,
pavimenti resistenti,
doghe per botti da vino e cognac (il celebre “rovere di Slavonia”),
e un tempo anche per navi e imbarcazioni. E le ghiande? Ottime per nutrire i maiali… e per attrarre fauna selvatica.
Come riconoscerla?
Foglie. Semplici, con 4–7 lobi arrotondati per lato, come piccole onde verdi.
Lunghe fino a 10 cm, con picciolo cortissimo.
Verde intenso sopra, più opache sotto. In autunno virano verso sfumature calde e rugginose.
Fiori. Maschili e femminili sulla stessa pianta (è monoica).
I maschili sono amenti penduli giallastri; i femminili, piccoli e discreti, si trovano all’apice dei rami.
Fioritura: aprile-maggio. Impollinazione a cura del vento.
Frutti. Le classiche ghiande, riunite a gruppetti di 2–3, sorrette da un peduncolo comune.
Maturano nell’anno stesso in cui si formano.
Tronco e corteccia. Tronco robusto e diritto, con rami forti e quasi orizzontali.
Corteccia grigia da giovane, poi brunoscura e profondamente fessurata in placche. Un vero monumento vivente.
Chioma. Ampia, irregolare, maestosa. Negli esemplari isolati si allarga come una grande corona verde.
La farnia è l’albero perfetto per chi sogna un gigante silenzioso che regala ombra e protezione.
Simbolo di divinità e vittorie
La farnia non è solo un albero: è un mito vivente. Nell’antichità era considerata sacra: albero di Giove, dio del cielo e della folgore. Presente nell’oracolo di Dodona, il più antico della Grecia. Romolo appese ai suoi rami le armi del nemico sconfitto, fondando il primo tempio a Roma. Le corone di foglie di quercia erano simboli di vittoria e onore militare. Ancora oggi, un ramo di quercia è raffigurato nello stemma della Repubblica Italiana, come emblema di forza e dignità.

Frassino comune: l’albero che tocca il cielo
Nome elegante, storia antica
Il suo nome evoca forza e protezione. Forse viene dal greco frasso, “difendo”, perché un tempo il frassino era usato per creare siepi robuste e impenetrabili.
Dove vive?
Il Frassino è una star dei boschi europei. Dalle pianure ai 1500 metri di quota, è diffuso in quasi tutta Italia, tranne in Basilicata, Calabria e Sardegna (dove è presente solo in modo sporadico).
Ama i luoghi freschi e umidi, spesso vicino a fiumi, torrenti e pendii boscosi, dove gioca un ruolo fondamentale per consolidare il terreno con le sue radici orizzontali.
Una forza della natura (e del design)
Il Frassino è un albero forte, veloce a crescere, elegante da vedere e… super utile!
Può vivere fino a 250 anni, e il suo legno bianco-venato è una vera eccellenza. Flessibile ma resistente,
non si scheggia,
non teme gli agenti atmosferici.
Con il suo legno si fanno:
- manici per martelli, picconi, accette
- remi, sci, stecche da biliardo
- le prime ruote delle automobili (!)
- alberi di barche e attrezzi sportivi (solo piante maschili nei frassineti da legno: producono materiale migliore perché non investono energie nei frutti)
In città viene scelto per alberature stradali: elegante, resistente allo smog e disponibile in tante varietà ornamentali (con foglie dorate, rosse, argentate…). Un vero top model del verde urbano!
Come si riconosce?
Foglie. Composte, imparipennate, con 9–11 foglioline lanceolate e seghettate. Verde scuro sopra, più chiaro sotto. Nascono tardi (maggio) e cadono presto (ottobre): il frassino resta spoglio per circa 7 mesi.
Fiori. Piccoli e curiosi: senza petali né calice, ma affascinanti! Maschi (con antere rosso vivo), femmine (verdi) e anche ermafroditi. Sbocciano prima delle foglie in primavera (marzo–aprile). Impollinati dal vento: anemofili.
Frutti. Samare: piccoli frutti alati, ellittici, con un seme decentrato. Riuniti in pannocchie pendule che restano a lungo sull’albero.
Tronco e corteccia. Alto, dritto, cilindrico, senza rami bassi. La corteccia, liscia da giovane, diventa grigio chiaro e rugosa con fessure a forma di “cratere”.
Chioma. Ampia, leggera e ariosa, lascia passare luce e vento. Da giovane è più ordinata, poi assume forme irregolari e affascinanti.
Miti e leggende
Il Frassino non è solo un albero, è un simbolo del mondo.
Per i Greci era l’albero felice, sacro a Nemesi e alle ninfe Melìe, nate dal sangue del cielo.
Nella mitologia nordica è Yggdrasil, l’albero cosmico che sostiene l’universo: una radice nel mondo degli dèi, una tra i giganti e una nella terra degli uomini. L’albero della conoscenza e del destino, con rami che toccano il cielo e radici che abbracciano il mistero.

Leccio: il re ombroso della macchia mediterranea
Nome tosto, cuore antico
Il nome Quercus? Viene da radici antiche, forse celtiche: kaer o quer, ovvero “bel albero” o, più poeticamente, “l’albero per eccellenza”.
Il termine ilex, invece, richiama le foglie spinose simili a quelle dell’agrifoglio e forse viene proprio da un’antica parola celtica che significa “punta”.
Insomma, anche solo dal nome si capisce che il leccio non è un albero qualunque.
Dove lo trovi?
Il Leccio è una vera icona del Mediterraneo: si adatta a suoli poveri, al vento salmastro e alla siccità come pochi altri.
In Italia cresce ovunque, tranne in Valle d’Aosta. Lo trovi in riva al mare, nei boschi aridi e persino fino a 1200 metri di altitudine.
È il protagonista assoluto della macchia mediterranea: quella vegetazione sempreverde, profumata e un po’ selvaggia che ci fa pensare subito all’estate.
L’albero coriaceo (in tutti i sensi)
Il Leccio è lento a crescere, ma quando prende piede, dura secoli: può vivere fino a 300 anni.
È rustico, resistente e instancabile: perfetto per parchi, giardini e alberature stradali, soprattutto nelle zone costiere. La sua chioma fitta e scura è l’ideale per creare ombra vera, quella fresca anche nelle giornate torride.
E il legno?
Durissimo, pesante, quasi impossibile da lavorare (gli artigiani lo sanno!). Ideale per oggetti che devono durare: torchi, attrezzi agricoli, parti di barche. Brucia a lungo: ottimo per il carbone. La corteccia ricca di tannini veniva usata per conciare le pelli. Le ghiande, invece, erano il “superfood” dei maiali e un tempo… anche un surrogato del caffè!
Come si riconosce?
Foglie. Sempreverdi, spesse e coriacee.
Verde scuro lucido sopra, bianche e pelose sotto (così trattengono l’umidità).
Possono avere margini interi, dentati o spinosi, a seconda dell’ambiente.
Le foglie giovani, soprattutto nei cespugli, sono spesso pungenti come un agrifoglio.
Fiori. Unisessuali, maschi e femmine sulla stessa pianta.
I maschili sono amenti penduli gialli (lunghi 4–6 cm), quelli femminili sono più piccoli, con stimmi rossi.
Fiorisce in primavera, tra aprile e maggio.
Impollinazione? Ci pensa il vento (anemofila).
Frutti. Le classiche ghiande ovoidali, lunghe circa 1–2 cm.
Racchiuse a metà in una cupola squamosa e pelosa.
Ottimo nutrimento per la fauna (e per gli allevamenti di un tempo).
Tronco e corteccia.Tronco contorto, spesso diviso alla base, con tanti rami fin dalla parte bassa. Corteccia scura, rugosa, che si sfalda in piccole placche con l’età.
Chioma. Fitta, compatta e di un verde così scuro da sembrare quasi nero. A seconda delle condizioni, può assumere forma arborea o arbustiva.
Un albero sacro (da sempre)
Il Leccio non è solo bello e forte: è anche profondamente simbolico.
Nell’antichità era considerato l’Albero sacro per eccellenza, amato da dèi e uomini. Consacrato a Era nella cultura greca. Nell’antica Roma attirava i fulmini: simbolo di potere e oracolo degli dèi. La ninfa Egeria, consigliera del re Numa, viveva in un bosco di lecci. Secondo la leggenda, la croce di Cristo fu costruita con il suo legno. E poi c’è Ovidio, che nel descrivere l’Età dell’Oro scrive:
“Scorrevano fiumi di latte, lì fiumi di nettare, e biondo miele stillava dal verde leccio…”
Una chiara allusione alla melata di Leccio, ancora oggi raccolta dalle api in estate!”

Pioppo bianco
Un nome, mille storie
Populus come “popolo”. Secondo i Romani, il fruscio delle sue foglie ricordava il mormorio di una folla. Il cognome alba, invece, dice già tutto: bianco. Bianche le foglie sotto, bianchi i giovani rami, bianca perfino la corteccia!
Dove vive?
Originario dell’Europa, dell’Asia occidentale e del Nord Africa, il Pioppo bianco è uno specialista delle zone umide. Cresce bene in pianura, collina e bassa montagna . Ama le rive dei fiumi, le zone paludose, i suoli profondi e limosi . Sopporta il vento, la salsedine, e non teme l’aria di mare . È una pianta colonizzatrice: arriva per prima dove gli altri non riescono a stare, come sabbie, golene e rive fresche. E lo fa con stile!
Caratteristiche da star
Il Pioppo bianco è un albero alto e slanciato, che può raggiungere anche i 30 metri.
È longevo (vive fino a 300 anni) e ha la simpatica tendenza a “moltiplicarsi”: emette polloni (nuovi alberelli) sia dal tronco che dalle radici, anche a decine di metri di distanza!
È molto apprezzato per il suo legno leggero e chiaro, perfetto per carta, fiammiferi, zoccoli, attrezzi
; la corteccia ricca di salicina (sì, quella dell’aspirina!)
; il suo portamento elegante nei parchi, viali alberati e giardini
.
Foglie: due facce della stessa bellezza
Le foglie del Pioppo bianco sono una vera meraviglia della natura: semplici, con picciolo lungo ; verde lucido sopra, bianco lanoso sotto (da qui il nome) ; cambiano forma a seconda dei rami: alcune sono lobate e dentate, altre ovate e lisce . Quando il vento le muove, creano un effetto cangiante, come se l’albero brillasse .
Fiori e frutti? Sì, ma separati!
Il Pioppo bianco è una pianta dioica: significa che i fiori maschili e femminili crescono su alberi diversi. I maschi hanno amenti rossi (poi gialli), lunghi e curvi
. Le femmine producono amenti verdi-grigiastri, più corti
Fiorisce tra febbraio e marzo, prima che spuntino le foglie
. L’impollinazione avviene per anemofilia: ci pensa il vento a far girare la voce (e il polline). In primavera, i frutti rilasciano semi piumosi che volano nell’aria come fiocchi di neve estiva.
Tronco, corteccia e chioma
Tronco diritto e robusto, spesso ramificato dalla base.
Corteccia prima verde, poi bianco-argentea, segnata da lenticelle romboidali e placche nere
. Chioma leggera, mai troppo densa, che si allarga con l’età
I rami si aprono con angoli variabili, creando forme diverse e affascinanti
Simboli, leggende, mito
Il Pioppo bianco ha ispirato poeti, eroi e dèi. Fetonte, figlio del Sole, osò guidare il carro infuocato del padre. Zeus lo colpì con un fulmine e il ragazzo cadde nel fiume Eridano (il nostro Po). Le sorelle, disperate, furono trasformate in pioppi, che ancora oggi piangono ambra.
Eracle, tornato dagli Inferi, si incoronò con foglie di Pioppo bianco: nere fuori per il fuoco dell’oltretomba, bianche dentro per la luce dell’eroe.
In Mesopotamia, 5000 anni fa, si seppellivano i defunti con corone d’oro a forma di foglia di pioppo: protezione per i viaggi nell’aldilà.

Pioppo tremolo: l'albero che danza con il vento
Un nome che dice tutto
Il suo nome deriva da quel movimento leggero e continuo delle foglie, causato da un picciolo lungo e super appiattito. Un meccanismo naturale tanto semplice quanto scenografico.
Dove vive?
Originario delle regioni fredde e temperate dell’Eurasia, il Pioppo tremulo è un vero globetrotter vegetale, diffuso in tutta Italia, dalla collina alla montagna, fino a quota 1500 m e oltre.
Lo trovi: nei boschi umidi, lungo i corsi d’acqua; lungo corsi d’acqua; su pendii instabili (che lui aiuta a consolidare); in terreni “difficili”, dove arriva come specie pioniera.
Cosa lo rende speciale?
Alto e slanciato (fino a 25 metri). Tremolante e vivo, anche nelle giornate calme. Produce una quantità incredibile di polloni, formando nuovi alberi tutto intorno – un vero sistema in espansione. È resistente, adatto a nuove colonizzazioni. Il suo legno chiaro viene usato per carta, fiammiferi, compensati e tanto altro
Insomma, non si ferma mai. Un vero multitasking naturale!
Foglie: una coreografia naturale
Semplici, rotondeggianti o ovali, con un bel margine dentato. Verde lucido sopra, grigio-pelose sotto
Ma il segreto è tutto nel picciolo: lungo, sottilissimo, appiattito.
È lui che fa “vibrare” le foglie con ogni soffio d’aria, creando un effetto ipnotico e musicale
Fiori e fiocchi di cotone?
Sì, anche il tremulo è pianta dioica: maschi e femmine vivono separati, ma in perfetta sincronia. I maschi fioriscono con amenti rosso-grigiastri, curvi, lunghi 8-10 cm. Le femmine sfoggiano amenti più lunghi, verde-rossastri, leggeri e flessibili. L’impollinazione avviene con il vento (anemofila), e tra marzo e maggio rilascia semi cotonosi che fluttuano nell’aria come fiocchi leggeri.
Tronco, corteccia e chioma
Il tronco è slanciato e regolare, perfetto da disegnare! La corteccia liscia, di un elegante grigio-verde, lo rende facilmente riconoscibile. La chioma si forma in alto, globosa e ariosa, con pochi rami e tanto spazio per ballare
Tra mito e leggenda
Anche il Pioppo tremulo ha un passato mitico.
Secondo i Greci, Fetonte, figlio del Sole, rubò il carro infuocato del padre per guidarlo nei cieli. Ma perse il controllo e Zeus lo fulminò. Le sue sorelle, addolorate, si trasformarono in alberi tremanti, che piangono ancora oggi lacrime di resina: i pioppi.
Queste lacrime, narrano le leggende, sono anche l’origine della preziosa ambra.

Quercus pubescens: la Roverella
La quercia che sa resistere
Maestosa, forte, un po’ ruvida ma affascinante. La Roverella è la quercia che non ha bisogno di lustrini per imporsi. Cresce dove gli altri cedono, regna sulle colline assolate e si spinge fino a monti aridi e pendii pietrosi. È l’essenza rustica per eccellenza. E se ti sembra che tenga le foglie morte tutto l’inverno… beh, è perché non molla mai. Nemmeno loro.
Dove la trovi?
Originaria dell’Europa meridionale, Asia occidentale e Caucaso, la Quercus pubescens è presente in tutta Italia, con una passione speciale per le pendici assolate delle Alpi meridionali (tra 200 e 800 m); le colline centrali e meridionali della penisola; le macchie siciliane e sarde.
Nei boschi si fa spesso compagnia con cerri, carpini, aceri, ornielli e un bel po’ di sottobosco chiacchierone.
Cosa la rende unica?
Foglie “pelose” (da qui il nome pubescens) con un tocco vellutato nella pagina inferiore. Chioma verde-grigiastro, densa, che può diventare un cespuglio in ambienti difficili. Defogliazione tardiva: perde le foglie secche solo in inverno inoltrato. Legno durevole e resistente all’acqua, perfetto per costruzioni navali, strumenti agricoli, traversine ferroviarie. Ghiande nutrienti, perfette per i suini e, in tempi antichi, persino per noi umani
Sì, hai letto bene: in passato le ghiande si mangiavano, si macinavano, si tostavano per farne caffè. E nei momenti duri erano cibo prezioso.
Foglie da manuale
Forma ovato-allungata, margini lobati (5-7 paia). Coriacee, resistenti, con pagina inferiore pubescente
Verde scuro sopra, vellutate sotto, come un abito da sera naturale. Picciolo corto, anch’esso peloso: la morbidezza è un tema ricorrente.
Fiori e… pollini al vento
Come tutte le querce, è monoica: fiori maschili e femminili sulla stessa pianta ma in zone diverse. Fiori maschili: amenti penduli, lunghi, giallo-verdi. Fiori femminili: piccoli, raccolti a gruppetti di 2-4. Fioritura? Ad aprile-maggio
Impollinazione? Grazie al vento (anemofila), quindi aspettati un po’ di “soffio botanico” in primavera
Ghiande da record
Lunghe circa 2 cm. Protette da una cupola legnosa con squame strette e regolari. Crescono direttamente sul ramo (sessili), a differenza di quelle della farnia. Usate da sempre per nutrire maiali, uomini e… la storia. Le trovi ancora oggi nei querceti da ghianda, specialmente in Toscana e nel Sud Italia.
Il tronco e la corteccia?
Rudi ma autentici. Tronco sinuoso, eretto, a volte scultoreo. Corteccia grigio scura, spezzettata in piccole squame. Rami giovani coperti da una soffice peluria bianca. Chioma ampia, a volte cespugliosa, sempre resiliente come poche
Simbolo di forza, storia e mito
La Roverella non è solo un albero. È un’icona culturale. Venerata dagli antichi, consacrata agli dei e alle ninfe
Nell’antica Roma era simbolo di vittoria: le corone civiche erano fatte di sue foglie. Oggi è uno dei rami dell’emblema della Repubblica Italiana, simbolo di forza e dignità. Callimaco racconta che le Ninfe e le Driadi nacquero proprio da lei.
Insomma, non è solo una pianta: è una divinità vegetale.

Salice bianco: l'albero poetico che danza con l'acqua e canta con il vento
L’anima gentile dei fiumi
Elegante, snello, con quella chioma che sembra sospirare nella brezza. Il Salice bianco è l’albero che più di ogni altro ama vivere vicino all’acqua. Laghi, fiumi, canali… ovunque ci sia umidità e terra fangosa, lui è lì e lo fa con stile leggero e chiome argentee che sembrano accarezzare l’aria.
Un nome, una storia
Salix: dal celtico sal lis, “vicino all’acqua”.
Alba: bianco, come le sue foglie cangianti, argentate sotto e verdi sopra.
Dove cresce?
Praticamente ovunque! Dall’Europa all’Asia fino al Nord Africa, il Salice bianco è un vero globetrotter. In Italia lo trovi dal mare alla montagna (fino a 1000 m di quota), sempre a zonzo per le rive umide e fangose, spesso in compagnia di pioppi neri e altra vegetazione acquatica.
Caratteristiche che conquistano
Raggiunge i 30 metri d’altezza con disinvoltura . Vive in terreni periodicamente sommersi . È perfetto per rinforzare argini, scarpate e zone franose . È stato il “salice da pertiche” delle campagne contadine: ogni 2-3 anni lo si capitozzava per ottenere rami elastici usati per legare le viti . Tollerante a vento e smog: un campione di resilienza urbana
Foglie, fiori, corteccia, tronco, chioma
Lunghe e affusolate, come dita eleganti . Verde scuro sopra, argentate sotto (effetto seta!) . Seghettate ai bordi, con picciolo corto . Quelle giovani sono coperte da un fitto velo sericeo: sembrano sfiorate da un pennello di luce.
Fiori? Amenti danzanti
Il Salice è dioico: fiori maschili e femminili su alberi diversi
. Maschili: gialli, eretti, lunghi 4-6 cm
. Femminili: più corti, verdi e delicati
. Fioritura a marzo-aprile, mentre spuntano le prime foglie
. Impollinazione? Grazie a insetti innamorati di nettare
.
Frutti e semi volanti
I frutti sono capsule lisce, piene di minuscoli semi
. Ogni seme ha un ciuffo cotonoso che lo fa volare: sembra neve di primavera
. Dispersi dal vento, conquistano nuovi terreni umidi
Tronco e corteccia
Tronco spesso diviso alla base, robusto
. Corteccia solcata, squamosa, color bruno-grigio
. Un look “vissuto”, che racconta storie di acqua e tempo
.
Chioma poetica
Ampia e ariosa, fino a 10 metri di diametro
. Rami verticali ma flessuosi, che si piegano e non si spezzano
La sua chioma sembra una carezza alla luce
.
Simboli e leggende
Sotto un salice, secondo la mitologia, Rea nascose Zeus ed Era per salvarli da Crono: il salice è da sempre custode e protettore . Nell’antico Egitto era sacro a Iside, dea madre e della guarigione . Associato alla luna, alle emozioni e alla poesia. Con la sua salicina (contenuta nella corteccia) si otteneva l’acido salicilico… sì, proprio quello dell’aspirina!
Le foto sono del Portale della Flora di Roma, Università degli Studi di Trieste. http://dryades.units.it/Roma